- Home
- Attività nelle scuole
- Finestre focus
- Letteratura ed esilio
- Ogni mattina a Jenin – Scheda 4
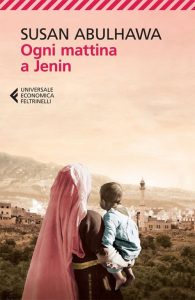
La trama
Il romanzo racconta la storia di quattro generazioni di palestinesi costrette a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di “senza patria”. È la voce di Amal, la nipotina del patriarca della famiglia Abuleja, a narrarci l’abbandono della sua casa, nel 1948, per il campo profughi di Jenin, e la tragedia dei suoi fratelli che si ritrovano a combattere su fronti opposti. Amal racconta la sua storia, l’infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e, infine, il bisogno di condividere tutto quello che ha vissuto con sua figlia, il suo amore più grande.
La storia della Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie palestinesi, si snoda nell’arco di quasi sessant’anni, attraverso gli episodi che hanno segnato la nascita di uno stato e la fine di un altro: la tragedia dell’esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi profughi, da rifugiati che vivono “sospesi” in attesa di una svolta.
Feltrinelli 2011, 390 pp.
Un brano
Fu così che, otto secoli dopo la sua fondazione ad opera di un generale dell’esercito del Saladino, nel 1189 d.C., a ‘Ain Hod non si videro più bambini palestinesi. Yehya cercò di calcolare il numero di generazioni che erano vissute e morte nel villaggio e arrivò a quaranta. Fu un compito facilitato dall’usanza araba di chiamare i propri figli in un modo da rendere evidente la genealogia, mettendo cinque o sei nomi della progenie diretta al bambino nell’ordine esatto. Yehya calcolò
quaranta generazioni di vite, ora spezzate. Quaranta generazioni di nascite e funerali, di matrimoni e danze, di preghiere e ginocchia sbucciate. Quaranta generazioni di peccati e carità, di cucina, duro lavoro e ozio, di amicizie, ostilità e accordi, di pioggia e corteggiamenti. Quaranta generazioni con i loro indelebili ricordi, segreti e scandali. Tutto spazzato via dal concetto di diritto acquisito di un altro popolo, che si sarebbe stabilito in quello spazio rimasto libero e l’avrebbe proclamato – con il suo patrimonio di architettura, frutteti, pozzi, fiori e fascino – retaggio di forestieri ebrei arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo. (pp. 50-51)
L’autore
Susan Abulhawa, cittadina statunitense, è nata da una famiglia palestinese in fuga dopo la “Guerra dei Sei Giorni” del 1967 e ha vissuto i suoi primi anni in un orfanatrofio di Gerusalemme. Si trasferisce negli stati Uniti da adolescente, dove si laurea in Scienze biomediche.
Autrice di numerosi saggi sulla Palestina, è stata insignita nel 2003 del premio Edna Andrade. Ha fondato l’associazione Playgrounds for Palestine, che si dedica ai bambini dei Territori Occupati. I suoi articoli sono apparsi su numerose testate, tra cui “The Huffington Post”, “Chicago Tribute” e “The Christian Science Monitor”. Ogni mattina a Jenin (2011), pubblicato in ventidue paesi, è il suo primo romanzo, bestseller internazionale.
Temi per la riflessione
• Il conflitto arabo-israeliano, iniziato nel 1948 e non ancora risolto, ha portato alla costruzione nel 2002 di una “barriera di sicurezza” in Cisgiordania, conosciuta anche come muro dell’apartheid.
La barriera che fisicamente divide Israele dai Territori palestinesi, è stata pensata come una soluzione alla violenza. Ma da strumento di difesa si è trasformata in una sorta di arma: il muro, infatti, non passa lungo la frontiera, ma nel profondo del territorio palestinese. Decine di migliaia di contadini palestinesi sono stati separati dai loro campi, alcuni villaggi sono circondati da ogni lato dal filo spinato e gli abitanti vivono di fatto una condizione di reclusione a cielo aperto. Nel luglio 2007 la Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha definito il Muro “contrario al diritto internazionale” e avrebbe domandato il suo smantellamento. Gli israeliani obiettano che, dalla sua costruzione, gli attacchi terroristici sono diminuiti del 90%.
• A seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente, con il compito di fornire assistenza e realizzare progetti a favore dei rifugiati palestinesi.
L’area geografica di attività dell’UNRWA è limitata a Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e striscia di Gaza. Solo quando si trovano fuori da tale zona, i rifugiati palestinesi rientrano nel mandato dell’UNHCR e nella Convenzione del 1951.
Fin dalla sua istituzione l’Agenzia ha svolto la sua attività sia in periodi di relativa calma, che di ostilità. Ha fornito cibo, alloggio e abiti a decine di migliaia di rifugiati in fuga e allo stesso tempo ha realizzato programmi di istruzione e di assistenza medica per centinaia di migliaia di giovani rifugiati.
L’UNRWA ha codificato una definizione ad hoc per i profughi palestinesi: “I profughi palestinesi sono persone il cui normale luogo di residenza era la Palestina tra il giugno 1946 e il maggio 1948, che hanno perso tanto le loro abitazioni quanto i loro mezzi di sussistenza come risultato della guerra”.
Lo status di rifugiato palestinese è diverso da quello di qualsiasi altro rifugiato nel mondo, basti pensare che è l’unico caso in cui lo status è ereditario.
L’UNRWA provvede attualmente al sostentamento di numerosi campi-profughi riconosciuti in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Tra questi il campo profughi di Jenin in cui è ambientato il romanzo.
Per approfondire
• Il conflitto israelo-palestinese oltre che lungo e sanguinoso è anche particolarmente carico di implicazioni ideologiche. Le sue rappresentazioni sono spesso sbilanciate da una parte o dall’altra ed è difficile districarsi tra la ricca bibliografia esistente, di livello molto diverso. Sempre utili sono le inchieste che cercano di approfondire il punto di vista di entrambe le parti in causa, come Muri, lacrime e za’tar. Storie di vita e voci dalla Palestina, di Gianluca Solera (Nuovadimensione, 2008). Attraverso incontri con l’attivissima società civile, con vescovi e professori, profughi e coloni, militanti e gente comune, l’autore ricostruisce il quadro di una terra confusa e spaccata. Il particolare che emerge tragicamente dal reportage è la totale, reciproca ignoranza tra giovani israeliani e giovani palestinesi.
• Il cinema è certamente un prezioso mezzo espressivo e divulgativo che può aiutare a comprendere contesti ed avvenimenti reali. Negli ultimi anni molti registi israeliani e palestinesi hanno realizzato cortometraggi e lungometraggi per dare visibilità alle loro iniziative concrete per la pace, ma anche per fornire letture originali del conflitto, più vicine alla vita quotidiana della gente comune. Nelle rassegne periodicamente organizzate da Associazioni o Istituzioni culturali è possibile vederne alcuni, ma segnaliamo anche il progetto Ticho, che raccoglie sul web (http://www.tichofilm.com) un database ogni giorno più ricco di film e documentari che non hanno visibilità nelle sale e in molti casi neanche nell’home video. Tra le opere in catalogo pertinenti al tema ricordiamo Arna’s Children (Israele/Olanda, 2003) di Juliano Meir Khamis e Daniel Daniel, dedicato al Freedom Theatre, il teatro per bambini creato nel campo profughi di Jenin nel 1989 da Arna Meir Khamis, madre del regista e coraggiosa attivista pacifista israeliana: Bilin my love di Shai Carmeli Pollak (Israele/Palestina 2006), che racconta la storia di un piccolo villaggio palestinese che cerca di resistere alle forze di occupazione israeliane usando la nonviolenza; Bridge Over The Wadi (Israele, 2006) di Barak & Tomer Heymann, che mostra come due anni dopo l’inizio della seconda Intifada un gruppo di genitori palestinesi ed ebrei abbiano fondato una scuola binazionale e bilingue nel villaggio palestinese di Ara in Israele.
Nei panni dei rifugiati: scheda 1

